Riflettiamo
Ma di tutte... è più grande l'amore...
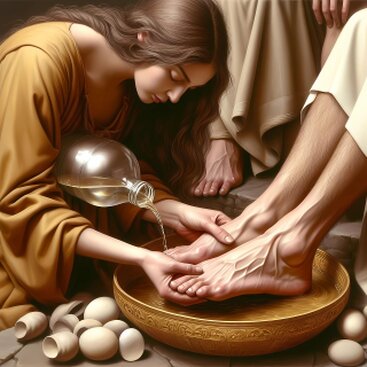
La carità, la più grande, è la virtù con la quale lo Spirito rinnova la facoltà di amare, invigorendola e assimilandola sempre più alla dinamica dello stesso amore che Cristo ha per il Padre e per il prossimo. Non è riducibile alle opere di elemosina o ai buoni sentimenti del filantropo, tanto meno l’amore cristiano è assimilabile all’erotismo.
Proviene, tramite lo Spirito di Cristo, dalla «grazia, misericordia e pace» (1Tim 1,2) di Dio Padre: “L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rom 5,5). Il segno più chiaro e strumento più efficace di tale carità (agàpe) è la Croce: «Non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi» (Rom 8,32). Anche per Paolo, dunque, vale già l’espressione agostiniana: “Se vedi la carità, vedi la Trinità” (De Trinitate, VIII, 8, 12), citata da papa Benedetto XVI nella Deus caritas est (n. 19): lo Spirito ci rende personalmente partecipi dei rapporti che intercorrono tra il Padre e il Figlio. E chi è “fervente nello Spirito” non renderà “a nessuno male per male” (Rom 12,11.17).
Lo Spirito di Dio-Amore dimora in noi fin dal battesimo (cf 1Cor 2,16; cf Rom 5,5; Gal 5,21) e ricevendo l’Eucaristia diventiamo sempre più un solo pane, un solo corpo (cf 1Cor 10,17; 12,27); si riceverebbe la propria condanna, se si partecipasse alla Cena del Signore con in cuore la divisione tra fratelli e con l’indifferenza per i loro bisogni (cf 1Cor 11,17-34).
Il primo frutto dello Spirito è l’amore (cf Gal 5,22) ed è generatore di comunione all’interno della comunità cristiana (cf 2Cor 13,13). L’unico Spirito dona a ciascuno i carismi e ministeri diversi, ma sempre per la utilità comune delle membra di uno stesso corpo, quello di Cristo (cf 1Cor 12,1-31).
Proprio trattando dei doni distribuiti liberamente dallo Spirito, Paolo scioglie il celeberrimo inno alla carità (1Cor 13,1-13), la «via migliore di tutte» (1Cor 12,31), delle tre la «virtù più grande» (1 Cor 13,13), il «vincolo della perfezione» (Col 3, 14).
Con la forza dolce della sua prosa ritmata, l’apostolo mette in luce in primo luogo il primato detenuto dalla carità sulle virtù umane e religiose (vv 1-3): cultura e doti mistiche; gli stessi tre doni come la profezia, la scienza («gnosis»), la fede che trasporta anche le montagne; perfino lo spogliarsi dei propri beni e l’eroismo di chi sacrifica la vita del corpo; tutto ciò, senza la carità, è decisamente vuoto del nulla, rimbombo di un gong, zero assoluto, vano spettacolo.
In secondo luogo (vv 4-7), l’inno descrive, elenca le opere che della carità sono frutto e segno, il corteo delle buone qualità che accompagnano l’amore autentico: apertura di cuore, bontà, umiltà, disinteresse, rispetto, perdono, pazienza; capacità di valorizzare l’altro e di infondere fiducia, di sopportazione dell’altro.
Da ultimo (vv 8-12), Paolo assicura che «la carità non avrà mai fine» (v. 8), mentre le altre virtù svaniranno con la raggiunta conoscenza perfetta, «faccia a faccia», di Dio.
Parlando della carità, (come in tutta la Scrittura, eccetto due volte nel Vecchio Testamento), Paolo usa il termine “agàpe“ e non quello di “eros“. Soprattutto a partire dalla cultura illuminista, si suole contrapporre il primo al secondo: “Agàpe” indicherebbe l’amore gratuito e offerto dall’alto, con il quale Dio ama l’uomo, la dedizione all’altro totalmente disinteressata e sofferta; “Eros” indicherebbe il desiderio/passione bramosi e possessivi, tesi alla propria esclusiva soddisfazione. Anche i medievali avevano distinto (e rischiato di contrapporre) l’amore di benevolenza e di dilezione dall’amore di concupiscenza. Paolo stesso confessa di avvertire drammaticamente il contrasto interiore tra la libertà non ancora liberata e la libertà liberata dalla grazia (cf Rom 7, 24s).
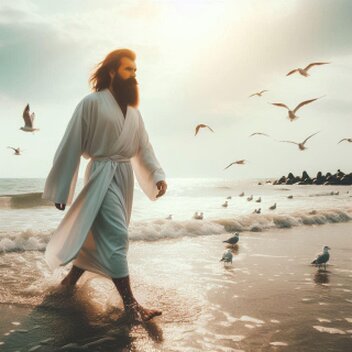 Invece, nell’enciclica Deus caritas est (nn. 3-12), Benedetto XVI fa scoprire nell’amore biblicamente ben inteso, differenza e unità tra “eros” e “agàpe”, la giusta unità nell’unica realtà dell’amore. “Eros” e “Agàpe”, l’amore ascendente e quello discendente, non sono mai completamente scindibili: nel vero amore umano, come in quello divino. Nella natura creata dell’uomo, spirito e materia si compenetrano sempre e profondamente (cf Gen 2, 23s). L’eros umano, all’inizio prevalentemente possessivo, se accoglie l’agàpe di Dio, è aiutato a purificarsi, passando anche da rinunce; e non perché da queste sia avvelenato e soffocato, ma per elevarsi, divenendo sempre più cura dell’altro, vita vissuta per l’altro. Fino all’estasi mistica nell’incontro con Dio, soltanto nel quale il cuore umano può trovare pace piena e definitiva: “Chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito” (1Cor 6,17). Ed anche l’amore con cui Dio ci ama (sempre “agàpe”) non è mai del tutto esente da “eros”. Il Dio biblico ha vera compassione del suo popolo e di ogni uomo (cf Os 11,8s; Cantico dei Cantici, ecc). Soprattutto sulla croce del Figlio, l’Amore incarnato di Dio. La carità del cristiano è dunque la forma e costituisce il valore di ogni virtù, la buona sostanza dell’essere comunionale, senza della quale ogni bene cessa di essere tale (cf 1Cor 13, 1-3). E tutti i membri della Chiesa - il corpo di Cristo «ben scompaginato e connesso», «secondo l’energia propria di ogni membro» - «vivendo secondo la verità nella carità» «riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità» (cf Ef 4,15s). Da qui le sue insistenti esortazioni intonate a questa essenziale virtù: «Ricercate la carità» (1Cor 14,1), «vivete in pace tra voi… non spegnete lo Spirito» (1Tes 5,12-19), «amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno» (Rom 12,10), «salutate i fratelli con il bacio santo» (2Tess 3,27); «Se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri, perdonatevi scambievolmente. Come il Signore ci ha perdonato, così fate anche voi» (Col 3,13).
Invece, nell’enciclica Deus caritas est (nn. 3-12), Benedetto XVI fa scoprire nell’amore biblicamente ben inteso, differenza e unità tra “eros” e “agàpe”, la giusta unità nell’unica realtà dell’amore. “Eros” e “Agàpe”, l’amore ascendente e quello discendente, non sono mai completamente scindibili: nel vero amore umano, come in quello divino. Nella natura creata dell’uomo, spirito e materia si compenetrano sempre e profondamente (cf Gen 2, 23s). L’eros umano, all’inizio prevalentemente possessivo, se accoglie l’agàpe di Dio, è aiutato a purificarsi, passando anche da rinunce; e non perché da queste sia avvelenato e soffocato, ma per elevarsi, divenendo sempre più cura dell’altro, vita vissuta per l’altro. Fino all’estasi mistica nell’incontro con Dio, soltanto nel quale il cuore umano può trovare pace piena e definitiva: “Chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito” (1Cor 6,17). Ed anche l’amore con cui Dio ci ama (sempre “agàpe”) non è mai del tutto esente da “eros”. Il Dio biblico ha vera compassione del suo popolo e di ogni uomo (cf Os 11,8s; Cantico dei Cantici, ecc). Soprattutto sulla croce del Figlio, l’Amore incarnato di Dio. La carità del cristiano è dunque la forma e costituisce il valore di ogni virtù, la buona sostanza dell’essere comunionale, senza della quale ogni bene cessa di essere tale (cf 1Cor 13, 1-3). E tutti i membri della Chiesa - il corpo di Cristo «ben scompaginato e connesso», «secondo l’energia propria di ogni membro» - «vivendo secondo la verità nella carità» «riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità» (cf Ef 4,15s). Da qui le sue insistenti esortazioni intonate a questa essenziale virtù: «Ricercate la carità» (1Cor 14,1), «vivete in pace tra voi… non spegnete lo Spirito» (1Tes 5,12-19), «amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno» (Rom 12,10), «salutate i fratelli con il bacio santo» (2Tess 3,27); «Se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri, perdonatevi scambievolmente. Come il Signore ci ha perdonato, così fate anche voi» (Col 3,13). Da quanto Paolo insegna sulla centralità di Cristo e del suo rapporto con il cristiano, consegue che nella vita quotidiana sono due gli atteggiamenti, tra loro inscindibili, che non ci devono abbandonare. Da una parte occorre coltivare l’umiltà e la riconoscenza di aver tutto ricevuto dalla sua grazia, vigilare perché nessun altro “idolo” sostituisca Cristo cui tutto è dovuto, affinché dalla libertà acquisita non si ricada nell’umiliante schiavitù.
D’altra parte, occorre alimentare la gioia e la fiducia di chi “è in lui”, radicalmente gli appartiene. Si tratta di seguire l’esortazione di Paolo: «Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo» (1Cor 11,1) e rimanere sulla roccia più stabile e sicura che si possa immaginare: «Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?» (Rom 8,31). Nessuno «potrà mai separarci dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore» (Rom 8,39); «Tutto posso in colui che mi dà la forza» (Fil 4,13).


